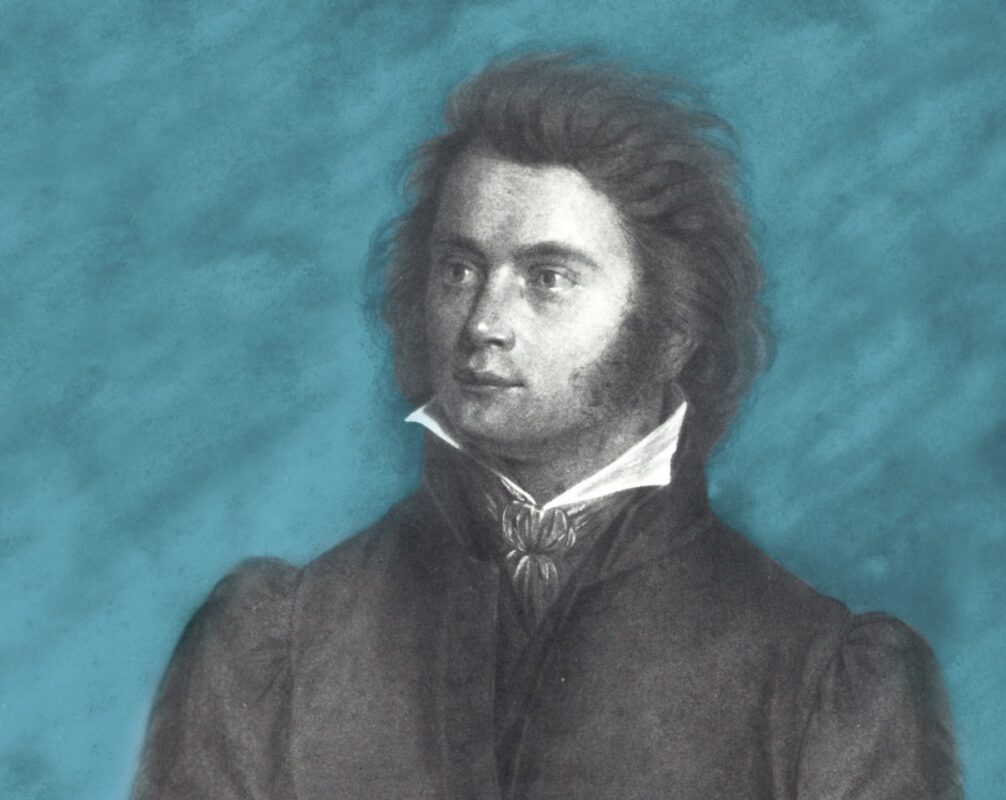Il Rabab medievale
All'inizio di novembre, l'Università delle Arti di Berna (HKB) ha ospitato la conferenza interdisciplinare internazionale "Il Rabab medievale. Uno strumento a corda con un passato e un presente arabo-islamico", che ha avuto luogo presso l'Università delle Arti di Berna (HKB).

È stato scelto un formato ibrido per adattarsi alla situazione pandemica. L'evento in loco è stato trasmesso simultaneamente online, tre relatori erano collegati e la discussione era possibile tra tutti i partecipanti, sia fisicamente che virtualmente presenti.
Il titolo principale della conferenza identifica già in modo specifico il suo centro concettuale: il rabab, un antico strumento a corde suonato nell'Europa medievale fino al 1300, oggi in gran parte perduto dalla tradizione musicale europea. La sua reintegrazione nella prassi esecutiva storica nell'ambito della musica antica è una delle principali preoccupazioni del progetto di ricerca interdisciplinare basato sulla HKB e sostenuto dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica. "Rabab & Rebec. Ricerca sugli strumenti a corda rivestiti di pelliccia del tardo Medioevo e del primo Rinascimento e loro ricostruzione".. La prima conferenza del progetto ha potuto contribuire a questo obiettivo con un'ampia contestualizzazione delle numerose fonti testuali, visive ed etnomusicologiche, non da ultimo localizzando esplicitamente lo strumento a corda nel suo passato e presente arabo-islamico, come dichiarato nel sottotitolo della conferenza.
A tal fine, i relatori di varie discipline hanno presentato un ampio spettro di questioni interconnesse provenienti da campi di ricerca spesso sovrapposti in un totale di 15 conferenze: musicologia storica, etnomusicologia, pratica musicale, iconografia musicale, storia dell'arte e linguistica. Si è spaziato dall'etimologia del termine, ai canali di distribuzione e al contesto funzionale dello strumento, dalle sue caratteristiche pratiche di esecuzione e tonali alle sue rappresentazioni pittoriche nell'arte e alla pratica attuale del Nord Africa. Andalusi-Musica.
Origini e ricostruzione
La conferenza è stata aperta da Thomas Gartmann (Berna), capo progetto e responsabile della ricerca presso la HKB, che ha presentato il capo progetto Thilo Hirsch (Berna) come spiritus rector del progetto di ricerca e della conferenza. Dopo l'introduzione al tema, una sezione è stata dedicata alle origini arabo-islamiche del Rabab che, in assenza di strumenti originali sopravvissuti, devono essere ricostruite a partire dalle fonti testuali di base. Dal punto di vista musicale translatio studiorum Anas Ghrab (Sousse) ha iniziato fornendo una panoramica di queste fonti testuali e dei meccanismi di questo trasferimento di conoscenze attraverso lo spazio e il tempo. Salah Eddin Maraqa (Friburgo) ha dimostrato in modo impressionante che è necessario un lavoro di investigazione filologica quando un termine caratterizza essenzialmente la concezione di uno strumento. Ha presentato nuove scoperte sull'etimologia del termine sulla base di un ampio studio critico delle fonti. Rabābmentre Ioana Baalbaki (Târgu Mureș) ha la posizione del Rabāb nell'ambito della teoria musicale dell'epoca sulla base del "Grande libro della musica" di al-Fārābī, il Kitāb al-Mūsīqā al-kabīr.
-

Foto: Daniel Allenbach/HKB
Al-Fārābī è anche colui che ha creato la Rabāb Il monocordo è stato menzionato per la prima volta esplicitamente come strumento ad arco nel X secolo, motivo per cui Laura de Castellet (Barcellona) si è concentrata sull'uso dell'arco e dei suoi canali di distribuzione insieme alla caratteristica posizione verticale di esecuzione nella sezione sulle fonti testuali e pittoriche utilizzate per la pratica e la teoria musicale. Saskia Quené (Berna), invece, ha collocato le rappresentazioni schematiche del monocordo all'interno della teoria musicale con un approccio artistico-scientifico come parte della teoria dell'armonia cosmologica, ricordando così che, secondo l'opinione medievale, la musica apparteneva al quadrivium del Arti liberali apparteneva a.
Le tavole rotonde orientate al metodo hanno completato il variegato programma di entrambe le giornate, seguendo tematicamente l'ultima conferenza. Il primo giorno si è trattato di una conferenza congiunta di Thilo Hirsch (Berna) e Marina Haiduk (Berna), che hanno presentato la bozza di una linea guida metodologico-pratica per la ricostruzione di strumenti musicali perduti. La loro proposta è stata concepita come una controproposta critica alla pratica comune di adottare indiscutibilmente le caratteristiche morfologiche dalle rappresentazioni pittoriche. Come questa base incerta possa essere utilizzata ai fini della ricostruzione pratica degli strumenti è stata discussa in modo controverso nel campo dell'iconografia musicale tra organologia e storia dell'arte, prima nelle tre co-presentazioni di Antonio Baldassarre (Lucerna), Theresa Holler (Berna) e Karolina Zgraja (Zurigo), poi nella successiva tavola rotonda. Per sua natura, il processo di negoziazione non ha potuto essere concluso. Tuttavia, l'identificazione delle aree problematiche e il dialogo interdisciplinare sono stati identificati come prerequisiti per lo sviluppo di prospettive fruttuose, in cui la sovranità interpretativa della propria disciplina può essere messa da parte a favore di un necessario scambio.
Occasione e pratica di gioco
Il secondo giorno è iniziato con una conferenza di Marina Haiduk, membro del progetto, che ha presentato una selezione di raffigurazioni di piccoli strumenti a corda tenuti in verticale tra l'XI e il XIII secolo e ne ha analizzato la distribuzione geografica e il contesto funzionale, evidenziando la loro presenza in pochi soggetti. Thilo Hirsch ha analizzato le raffigurazioni di Rabab nel Cantigas de Santa MaríaQuesti manoscritti della cerchia di Alfonso X forniscono informazioni sui tipi di rabab europei con coperture di pelliccia diffusi nella penisola iberica nel XIII secolo. Il rabab, ricostruito a partire da una delle miniature di Hirsch, è stato presentato al pubblico per la prima volta e ci si è interrogati sul suo uso pratico nella musica.
Le due sezioni successive, presiedute da Martin Kirnbauer (Basilea) e Britta Sweers (Berna), si sono concentrate sui seguenti temi Rabāb come parte della pratica musicale del Nord Africa contemporaneo e del suo recente passato (Mohamed Khalifa, Francia, e Anis Klibi, Tunisi). Amedeo Fera (Lovanio) e Vincenzo Piazzetta (Lamezia Terme) hanno presentato la lira calabrese ad arco e le sue origini bizantine, soffermandosi sul rapporto tra gli strumenti. Le due conferenze successive si sono concentrate sugli strumenti a pizzico con copertura in pelle: Emin Soydaş (Çankırı) ha analizzato la lira turca a pizzico e le sue origini bizantine. Kopuzmentre Sylvain Roy (Francia) ha aggiunto gli strumenti a pizzico del tipo Sarinda all'Afganistan. Rubāb in relazione tra loro. La conferenza di Ed Emery (Londra) ha fatto da transizione a questi interrogativi etnomusicologici, analizzando sia l'influenza della musica di al-Andalus nella tradizione europea, oltre a presentare i piccoli strumenti a corda come parte delle culture nomadi che possono essere fatte risalire ai trovatori itineranti del Medioevo.
Infine, un dialogo intradisciplinare tra l'etnomusicologa Britta Sweers (Berna) e Cristina Urchueguía (Berna), rappresentante della musicologia storica, ha esaminato le responsabilità, le analogie e le differenze tra le due (sotto)discipline. Le questioni considerate da diverse prospettive, ad esempio sulla storicità e l'autenticità, sono state infine colte come occasione per concludere la conferenza con una discussione estesa alla sessione plenaria. Infine, in una sessione informale di jam session, i relatori tunisini e marocchini Rabābs nonché le ricostruzioni di strumenti a corda europei (Rabab e Lyra).
-

Foto: Daniel Allenbach/HKB
I contributi della conferenza saranno pubblicati in forma riveduta in un'antologia da Edition Argus. È già in programma una seconda conferenza di progetto.