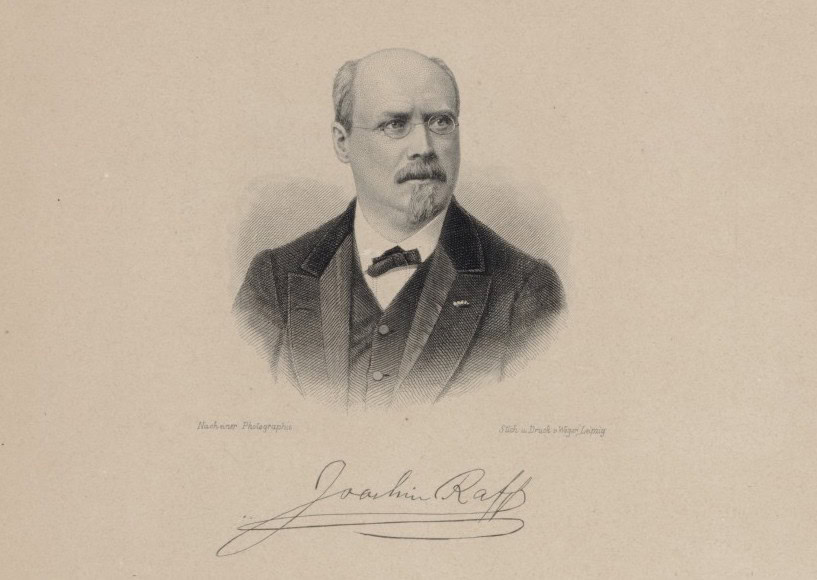Opere dispensabili e indispensabili
Antonín Dvořák aveva probabilmente buone ragioni per distruggere tre dei suoi quartetti per archi.

I due quartetti per archi n. 2 (1869?) e n. 5 (1873) sono esemplari del dilemma che le generazioni successive si sono trovate ad affrontare nel decidere quali opere di un grande compositore - soprattutto se già stimato in vita - debbano essere considerate tipiche e riconosciute sulla base del suo giudizio, e quali no.
L'autocritica distruttiva di Johannes Brahms e di altri e le conseguenti - spesso presunte - grandi perdite sono state oggetto di molte speculazioni e discussioni. L'idea che un compositore che ha raggiunto la fama grazie a numerosi capolavori debba essere sempre stato brillante e grande può essere respinta solo con l'aiuto del buon senso. Persino Mozart e Beethoven, garanti di frutti dello spirito apparentemente eternamente validi e in linea diretta con l'ispirazione divina, hanno prodotto materiale musicale banale, non vincolante, dispensabile, che può benissimo cadere nell'oblio generale senza produrre alcun serio sentimento di perdita. Non dovremmo forse supporre che coloro che erano i migliori conoscitori del proprio lavoro fossero anche i migliori giudici del suo valore assoluto? Un quintetto per clarinetto di Dvořák, un ottetto con pianoforte - persi!!! Tendiamo a piangere la perdita di opere dubbie (di transizione o di importanti fasi di sviluppo) piuttosto che intendere la loro distruzione da parte dei loro creatori come un necessario processo di purificazione della loro opera nel suo complesso, il che rende ancora più chiaro il valore delle opere rimanenti. La curiosità ci spinge a cercare ciò che non dovrebbe più essere esplorato.
L'intenso dialogo di Dvořák con Wagner e Liszt, a partire dal 1863, fu così epocale che egli mise la propria opera al servizio di altri grandi compositori senza riuscire a muoversi in modo convincente in questi panni troppo grandi. In questa fase di idolatria furono composti tre quartetti (re maggiore, mi minore, si bemolle maggiore), le cui partiture Dvořák in seguito distrusse, avendo identificato la strada intrapresa come sbagliata. Purtroppo - è quasi il caso di dirlo - sono sopravvissuti dei set di parti in proprietà privata, che hanno portato al trasferimento dei pezzi che non erano più graditi alla massima autorità, l'autore stesso. In particolare, il quartetto in si bemolle maggiore, della durata di 50 minuti, con i suoi infiniti intrecci tematici e la sua incomprensibilità semi-improvvisata, è un mostro acustico e una perdita di tempo di prim'ordine per qualsiasi esecutore. Può essere accettabile come studio di un vicolo cieco compositivo, ma non serve a nulla di più.
Il quinto quartetto del compositore, risvegliatosi da un sonno profondo e diventato lucido, è completamente diverso. Qui Dvořák trova il suo stile individuale, tornando a linee guida formali tangibili, a un'affermazione emotiva, a vigore, verve e sensualità. Naturalmente, nessuno dei capolavori successivi dovrebbe essere accostato a questa opera, ma l'ignoto della partitura dovrebbe essere portato gioiosamente alla luce in concerto, lasciandosi trasportare senza preconcetti e sentendo dove si trovano realmente le origini dell'incontestabile maestria successiva. Dvořák non era un artista precoce, né un bambino prodigio, ma un musicista laborioso la cui lotta per il proprio suono ha prodotto anche beni trascurabili. Il quartetto in si bemolle maggiore dovrebbe rimanere nascosto agli occhi del mondo, ma il quartetto in fa minore dovrebbe essere eseguito più spesso!
Antonín Dvořák, Quartetto per archi n. 2 in si bemolle maggiore B 17, a cura di Antonín Pokorný e Karel Šolc, parti, BA 9540, € 24,95; partitura di studio, TP 540, € 18,95, Bärenreiter, Praga 2014
Antonín Dvořák, Quartetto per archi n. 5 in fa minore op. 9, a cura di Jarmil Burghausen e Anton Cubr Parti, BA 9545, € 17,95; partitura di studio, TP 535, € 16,50, Bärenreiter, Praga 2014